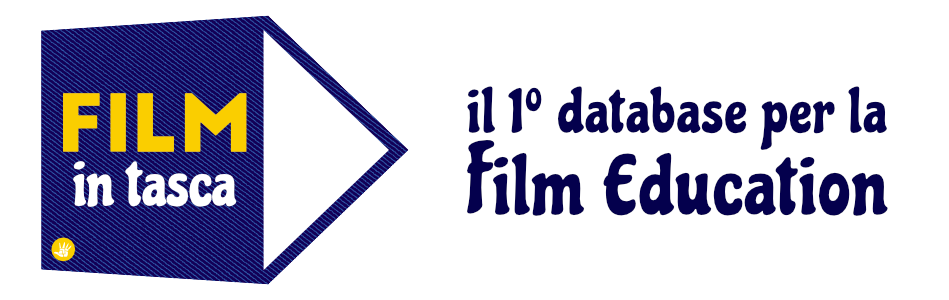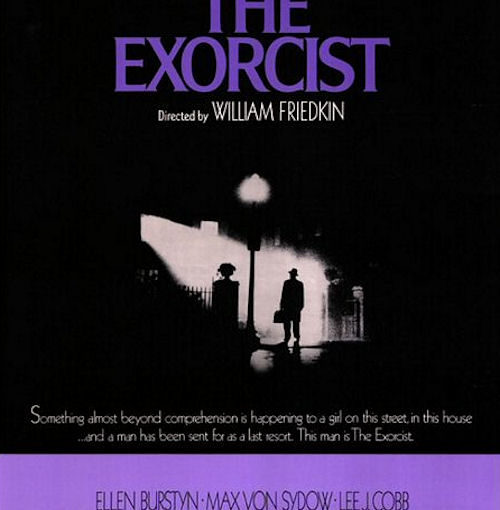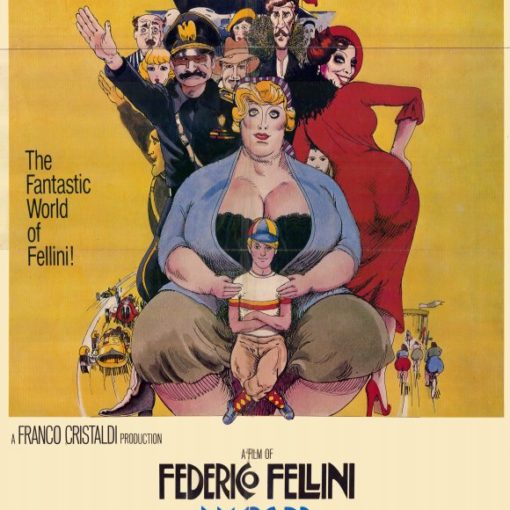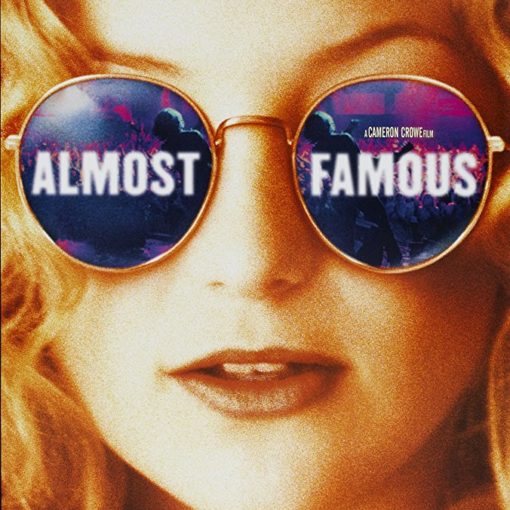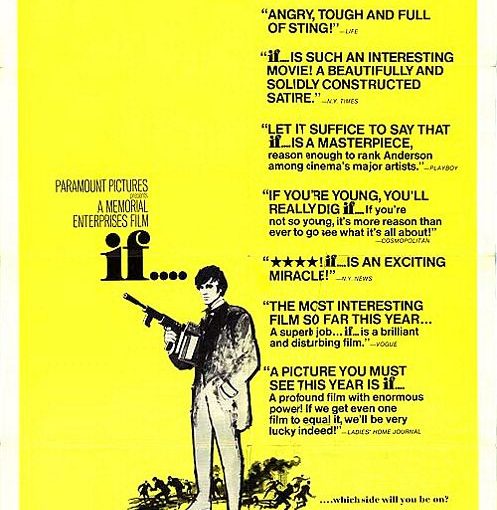Die Blechtrommel, Francia-Germania 1979/ Durata (min) 150′
Genere: Drammatico
Regia:
Völker Schlöndorff
Cast: Mario Adorf (Alfred Matzerath), Angela Winkler (Agnes Matzerath), David Bennent (Oskar Matzerath), Katharina Thalbach (Maria Matzerath), Daniel Olbrychski (Jan Bronski), Tina Engel (Anna Koljaiczek giovane), Berta Drews (Anna Koljaiczek adulta), Roland Teubner (Joseph Koljaiczek), Tadeusz Kunikowski (lo zio Vinzenz), Andréa Ferréol (Lina Greff), Heinz Bennent (Greff), Wigand Wittig (Herbert Truczinski), Mariella Oliveri (Roswitha), Charles Aznavour (Sigismund Markus);
Fascia età personaggi: infanzia
Sinossi
1899, Danzica. Agnès viene concepita durante un inseguimento rocambolesco del padre da parte della polizia. Venticinque anni dopo, nel 1924, nasce Oskar Matzerath, figlio di Agnès e di due potenziali padri, Alfred Matzerath, il marito della madre e Jan Bronski, il cugino. Il giorno del suo terzo compleanno, Oskar, disgustato dal mondo degli adulti, decide di non crescere né di separarsi mai più dal suo tamburo di latta, unico strumento di difesa dal mondo circostante. Cambierà idea solo vent’anni dopo, nel 1945, quando, rimasto orfano, si risolverà a diventare adulto. La madre si è suicidata, perché non riusciva più a vivere divisa tra i due uomini. La guerra si è portata via sia lo zio Jan ucciso dai nazisti, sia il padre Alfred ucciso dai russi. Oskar è costretto a separarsi anche dalla nonna per fuggire dalla Polonia verso un nuovo destino, con quel che resta della sua famiglia: la matrigna e il fratellino. Inevitabile, a quel punto, la decisione di crescere.
Critica
Oskar è affetto da nanismo. Più che una malattia il suo è un vero e proprio rifiuto a diventare adulto. Gli è bastato poco per capire che il mondo dei grandi è disgustoso e rivoltante. Il giorno del suo terzo compleanno, dopo l’ennesimo litigio tra i genitori e dopo essersi reso conto del desolante ambiente borghese in cui si ritrova, risoluto, decide di bloccare la sua crescita: in un atto rappresentativo che simboleggia il ritorno all’utero materno, si lancia nella botola della cantina e da quel momento in poi il suo corpo non si svilupperà più. Ma solo la sua forma rimane invariata perché il cervello e gli istinti sessuali progrediscono, indifferenti all’immutabilità fisica di Oskar. La forbice tra aspetto esterno e realtà psicologica del personaggio si allarga così di anno in anno, la sua duplice e contraddittoria essenza si fa sempre più stridente, tanto che il bambino/adulto manterrà le caratteristiche di entrambe le età. Questa contraddittoria duplicità, l’essere diavolo e angelo insieme, l’essere una figura estranea a ogni schematismo, a ogni univocità, a ogni omologazione, l’essere, in una parola, un anarchico, permette a Oskar di giudicare con acume e sarcasmo la società che ha intorno. Il suo sguardo severo si posa sulla violenza, diretta e indiretta, della quale è imbevuto il mondo adulto. Oskar diventa metafora esplicita della Germania. Anche se non è ambientato nella nazione di origine del regista, il film parla direttamente ai tedeschi e racconta di un paese ancora al suo stato infantile che ha deciso di non crescere, di non maturare, preferendo affidarsi, così come Oskar, a una truppa di nani in divisa, i nazisti. La dittatura appare, grazie allo sguardo eversivo del bambino/nano, nei suoi lati più grotteschi e paradossali. Il tamburo di latta è, infine, un apologo sulle brutture della guerra. In qualsiasi schieramento Oskar finisca, qualsiasi esercito ci sia in campo, il conflitto armato causa la morte delle persone che circondano il protagonista: lo zio Jan, il padre Alfred, l’amico venditore di giocattoli, la compagna Roswitha Raguna. Solo la fuga da quella dinamica e la ferma intenzione di crescere daranno finalmente a Oskar la possibilità di liberarsi da una situazione sociale divenuta ormai troppo stretta per i suoi minuscoli panni. La guerra è un gioco troppo infantile perché un bambino ne sia anche complice.